Ivana Pais è professoressa ordinaria di Sociologia economica presso l’Università Cattolica di Milano. Da tempo svolge attività di ricerca sui temi dell’ economia collaborativa e del lavoro digitale. Numerose le sue pubblicazioni tra cui le più recenti “Crowdfunding: la via collaborativa all’imprenditorialità” con Paola Peretti e Chiara Spinelli e “Il tassello mancante. L’intervento organizzativo come leva strategica per la transizione tecnologica” con Anna Maria Ponzellini.
In merito all’economia delle piattaforme si segnala: Stark, D., & Pais, I. (2020). Algorithmic management in the platform economy. Sociologica, 14(3), 47-72.
Da tempo sentiamo parlare di economia delle piattaforme e di concetti come sharing economy, gig economy e digital economy. Può fare chiarezza tra tipologie, modelli di business e di governance di questi ecosistemi in cui sfumano le distinzioni tra produttori e consumatori, tra lavoro retribuito e hobby?
Ho iniziato a studiare le piattaforme quando ci si riferiva a questo fenomeno parlando di sharing economy. Eravamo alla fine del primo decennio del secolo, subito dopo la crisi economico-finanziaria del 2008. A quel tempo si cominciavano a notare e quindi ad analizzare alcune piattaforme digitali (alcune nate anni prima) e l’etichetta che si utilizzava allora era quella di economia della collaborazione, della condivisione. Questo perché le piattaforme in quel momento rispondevano a un’esigenza chiara e piuttosto diffusa di ripensare i fondamenti dell’economia. Uscivamo dalla crisi economico finanziaria del 2008 che gli economisti non avevano previsto (eccetto Nouriel Roubini ndr); risuonava dalle aule della London school of economics la domanda della Regina Elisabetta rivolta a tutti gli economisti: come mai non avete previsto quello che stava arrivando?; e non c’era convegno in cui non compariva la slide con l’ideogramma cinese della parola crisi e qualcuno che chiosava: questo ideogramma vuol dire al tempo stesso pericolo opportunità (che poi non era vero a detta di tanti esperti linguisti e sinologi).
Insomma il clima era di messa in discussione di un impianto economico fondato su principi non sostenibili, un grande desiderio di ripensamento: di un’economia alternativa.
In quel clima alcuni attivisti, hanno visto la possibilità di costruire una economia basata sul rapporto tra pari e che prometteva la possibilità anche di socializzare l’economia in un mondo che era sempre più individualizzato.
Una traiettoria che guardava anche al riuso e alla parsimonia.
Esatto. C’era la dimensione del riuso e del risparmio, dell’ottimizzazione delle risorse scarse e della valorizzazione delle risorse non utilizzate. Quindi una prima sensibilità all’economia circolare che in quegli anni iniziava ad emergere e che sarebbe esplosa dopo.
Insomma, rispondeva veramente a tutte queste sensibilità che erano anche delle famiglie e non solo delle attività economiche in difficoltà.
Quindi, sull’onda di esigenze micro e macro e di una corrispondenza vera con lo spirito dei tempi, le piattaforme iniziano a diffondersi.
Ma non va come previsto in prima istanza.
Infatti col tempo alcune aziende basate sul modello piattaforma hanno iniziato ad usarle per fare business più che tradizionale: in due parole per fare business estrattivo che ha dato luogo a una critica serrata del concetto di sharing economy, quando invece sarebbe stata opportuna una risposta più circostanziata.
In che senso?
Voglio dire che è mancata una capacità analitica in grado di distinguere tra i diversi modelli economici incorporati nelle piattaforme. Ciò avrebbe aiutato a non fare di tutta l’erba un fascio e a non criticare la sharing economy tout court per una ragione semplice: quella non era sharing economy. Semmai quello che si poteva dire è che quei modelli più estrattivi stavano diventando in virtù della loro forza economica e finanziaria, il modello di riferimento e stavano di fatto assorbendo l’economia collaborativa che, per questa ragione, non si stava realizzando.
È da questa critica che nasce il concetto di Gig economy?
Sì, la gig economy diventa il concetto che indica un modello di organizzazione del lavoro basato su prestazioni frammentate, su lavoretti all’insegna della collaborazioni non riconosciute e non contrattualizzate, il cui simbolo sono i riders che vediamo scorrazzare nelle nostre città.
E adesso a che punto siamo?
Adesso siamo in un momento in cui, superata l’ondata di favore verso la sharing economy e quella di critica, finalmente le acque si sono un po’ fermate e c’è una maggiore attenzione a studiare il modello della piattaforma inteso innanzitutto come modello organizzativo.
Lo sforzo è quello di capire quali siano le caratteristiche di questo modello e se possa essere considerato diverso da altri modelli organizzativi. Se un modello, nato nelle piattaforme, può diventare un riferimento anche per altre aziende che piattaforma non sono; come è successo in passato per altri modelli organizzativi: ad esempio il fordismo, nato nel settore delle automobili e poi incorporato in toto o in parte in tanti altri settori. Questa è la prima cosa che ci stiamo chiedendo ma ce n’è anche un’altra.
Ovvero?
L’altra cosa che ci stiamo chiedendo è se questo modello di piattaforma possa essere interpretato e agito con logiche diverse. In altri termini se il modello basato sulla piattaforma possa avere varianti non estrattive e riprendere quello spirito delle origini della sharing economy. In questo solco si inserisce anche la riflessione sul Platform cooperativism lanciato da Trebor Scholz e la riflessione attorno a un modello non più estrattivo di valore per pochi, ma collaborativo, cooperativo. Insomma, un modello di piattaforma diverso che presuppone e favorisce un modello di sviluppo diverso; con capacità di radicare nei territori e quindi su una scala più locale; perché non esistono solo piattaforme multinazionali, ma anche quelle di casa nostra dove dobbiamo guardare le caratteristiche che stanno assumendo e vedere se corrispondono di più al futuro di un’economia desiderabile.

Secondo una recente ricerca dell’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (Inapp) la pandemia sembra aver accelerato la “piattaformizzazione” della società. Quali sono secondo te le traiettorie principali di questo processo?
Quello che stiamo vedendo è un duplice fenomeno. Da un lato la diffusione delle piattaforme intese come infrastruttura digitale che facilita l’incontro tra domanda e offerta di beni, servizi, informazioni e relazioni, che ormai sono diventate pervasive nella nostra vita quotidiana. L’altro fenomeno da osservare è quello a cui facevo cenno prima quando parlavo di modelli organizzativi dove assistiamo a logiche originate con le piattaforme che stanno diventando pervasive nelle modalità di organizzare il lavoro.
Puoi farci un esempio?
Un esempio evidente a tutti, riguarda i sistemi reputazionali. I sistemi reputazionali sono alla base del modello piattaforma perché la reputazione ha sostituito la fiducia come logica di costruzione della relazione. Questi meccanismi reputazionali sono connaturati al modello piattaforma e la logica reputazionale sta diventando sempre più rilevante in qualunque sfera sia del mercato del lavoro, sia della nostra società. Si tratta di un aspetto di grande rilevanza in quanto investe il ruolo del consumatore finale chiamato a valutare l’operato sia dei fornitori che degli operatori delle piattaforme. Ma che ha ripercussioni più ampie.
Quali ripercussioni?
Quello della reputazione è in realtà un meccanismo perverso. Tutta la robusta letteratura scientifica che abbiamo ci dimostra, senza ombra di dubbio, che questi meccanismi, non funzionano e non solo perché “drogati” per mancanza di controllo e pertanto soggetti a frodi.
Ma anche quando non c’è la frode accade che ci siano dinamiche legate all’atto sanzionatorio (una cattiva recensione ad esempio) che “alterano” i risultati che dovrebbero restituire la reputazione finale.
Ci spieghi meglio questo passaggio?
Noi sappiamo bene che per una persona, mettere in atto un comportamento sanzionatorio ha dei costi non solo per chi riceve la sanzione, ma anche per chi sanziona. Tutti, chi più chi meno, siamo chiamati e talvolta obbligati a sanzionare. Ad esempio il mio ruolo di docente mi riconosce tale ruolo: sono pagata per valutare e pertanto sanzionare gli studenti, ma non è qualcosa che faccio con piacere; mi costa fatica farlo, così come costa fatica a un genitore sanzionare in continuazione il proprio figlio piccolo. Ma qui c’è una contropartita: il genitore lo fa perché ritiene di fare il bene del proprio figlio.
Nel caso delle piattaforme qual è il ritorno del comportamento dell’atto sanzionatorio? L’unica situazione in cui una persona che utilizza una piattaforma, ottiene un riconoscimento dall’aver dato una valutazione negativa è quando viene trattata così male che la valutazione negativa diventa una specie di risarcimento simbolico.
Si tratta però di casi limite. In tutte le situazioni intermedie, chi valuta non ha nessun interesse a dare una valutazione che non sia positiva. Il risultato è che in generale le valutazioni sono poche rispetto al numero di coloro che interagiscono sulla piattaforma e tra quelli che valutano la maggior parte dà voti molto alti, una piccola parte dà voti molto bassi e tutta la fascia intermedia è perlopiù assente in quanto investita da quella fatica del sanzionare di cui dicevamo prima.

E questo fenomeno orienta gli acquisti, mi sembra di capire.
Certamente e le piattaforme hanno tutto l’interesse a fare in modo che le cose restino così e si guardano bene dall’avere un meccanismo realmente efficace; perché il cliente che va sulla piattaforma e trova valutazioni molto positive sarà incoraggiato a fidarsi della piattaforma e a mettere in atto un comportamento che favorisce il consumo. Il risultato è un meccanismo che grazie alla sua inefficacia, ha un impatto notevole sul comportamento delle persone che agiscono tramite la piattaforma.
Un meccanismo che cambia le dinamiche di consumo, le modalità di relazione e anche quelle di potere perché crea un’alleanza spesso implicita tra piattaforma e cliente finale. Un’alleanza che tra l’altro è dirompente perché porta, proprio in virtù del modello organizzativo, a rafforzare forme di monopolio o oligopolio.
Con buona pace dell’antitrust…
L’Antitrust è stato istituito per combattere i monopoli e gli oligopoli, ma alla base aveva la tutela del consumatore. Oggi se si intervistano i clienti finali, nessuno è insoddisfatto.
La parte debole nel gioco, non più a due (produttore e consumatore) ma a tre (produttore, consumatore e piattaforma), almeno in questo momento, non è il cliente finale, ma è il fornitore di servizi che opera attraverso la piattaforma e che viene schiacciato da questa alleanza tra la piattaforma e il consumatore finale. Alla fine chi viene penalizzato è chi lavora per produrre qualcosa o per offrire un servizio.
A proposito di lavoro, l’economia di piattaforma sembra ridisegnare tali lavori (talvolta riproponendo antiche pratiche come il cottimo), ma anche la spazialità e il nostro rapporto con il tempo. Come sta cambiando il lavoro e con esso l’architettura sociale del nostro vivere?
Non vorrei addentrarmi nel campo giuslavoristico che non è il mio, ma è evidente a tutti che il diritto e le tutele del lavoro si sono costruite a partire da uno spazio, un luogo di lavoro, e da un tempo di lavoro che oggi sono fortemente messi in discussione dall’economia delle piattaforme digitali che ridisegna non solo i modi di lavorare ma anche quelli di comunicare.
E ancor di più dopo la pandemia?
Oggi è ancora più stimolante e urgente agire in maniera opportuna, perché se questi temi prima della pandemia riguardavano quasi esclusivamente i freelance e pochissimi lavoratori dipendenti, oggi sappiamo bene che, dopo aver sperimentato in maniera forzata queste forme di lavoro, anche per i lavoratori dipendenti c’è stata un’accelerazione provocata dalla pandemia.
Oggi abbiamo una situazione in cui i lavoratori di diverse categorie chiedono in larga misura, flessibilità di spazio e di tempo e bisognerebbe capire il set di motivazioni per ognuna delle categorie. Oppure un aspetto che mi incuriosisce molto, ma che non ho ancora avuto modo di affrontare con una ricerca approfondita, è la relazione tra questo tema e i giovani, perché i giovani chiedono con forza lavoro flessibile. Tanto da indurli a non candidarsi per posizioni alla loro portata o a rifiutare il lavoro se non ha caratteristiche di flessibilità di spazio e tempo.
Per i giovani è molto più difficile implementare forme adeguate di lavoro agile perché ci troviamo di fronte a un’ambiguità tra richiesta di flessibilità e socializzazione al lavoro che passa soprattutto da contesti informali.
E il lavoro da remoto, se è vero che garantisce flessibilità e favorisce, in maniera spesso molto efficace, il lavoro formale, non è altrettanto efficace nelle dinamiche di apprendimento che passa non solo dal lavoro formale, ma soprattutto da momenti informali.
Vuoi dire che il lavoro agile senza prossimità limita quella che John Dewey chiamava “educazione accidentale”, quella roba che impari mentre vivi e non necessariamente ex cathedra o tramite un corso di formazione strutturato?
C’è uno filosofo Michael Polany fratello del più noto Karl autore de “La grande trasformazione” cha ha studiato le conoscenze informali e che ha studiato quello che oggi chiameremmo apprendimento organizzativo. Ebbene Polany ha posto l’attenzione sull’apprendimento di norme che passano in modo informale e che vanno a costituire l’identità professionale del lavoratore. Un’identità che si costruisce sovente più nei commenti che si fanno a margine di una riunione fisica, e che nel lavoro da remoto non c’è più.

È vero però che a margine di una riunione on-line o durante la stessa, scatta il canale parallelo dei messaggi whatsapp o delle telefonate…
Certo, ma questo viene fatto da chi una relazione ce l’ha già, non certo dal neo assunto che a margine di un commento fatto in presenza può ascoltare cose da parte di colleghi con più anzianità e esperienza che gli sarebbero altrimenti precluse.
Con questo non voglio dire che lo smart working è da ridimensionare.
Io sono assolutamente una sostenitrice del lavoro da remoto, perché per tante attività oltre che per un equilibrio generale vita-lavoro, un utilizzo intelligente del lavoro da remoto è sicuramente uno strumento a disposizione, da valorizzare e da utilizzare.
Però, proprio perché sostengo questo strumento, ritengo anche che dobbiamo dirci chiaramente quali sono i punti di debolezza dello strumento e gli aspetti per cui non è efficace.
Quali possono essere i rimedi per compensare questo deficit di relazione e di apprendimento informale che il lavoro su piattaforma si porta dietro?
Alcune aziende stanno sperimentando. Ci sono aziende che organizzano aperitivi da remoto e poi c’è il fenomeno delle radio aziendali che sta vivendo un boom conseguente alla rivalutazione dell’audio e alla diffusione dei podcast ad esempio.
Sono esperimenti interessanti che tentano di reintrodurre la dimensione di informalità e mantenere lo stesso sapore della relazione in presenza.
È veramente difficile riuscire a trasferire informazioni e conoscenza non codificata da remoto e secondo me è una delle sfide organizzative più impellenti dei prossimi anni.
Da tempo si riflette sul cosiddetto “free labour” ovvero quel lavoro gratuito fatto in gran parte di produzione e condivisione di contenuti prodotti per alimentare reputazione e community (o magari solo il proprio ego). È sufficiente non considerare questo lavoro come tale per derubricare il tema?
Non credo si possa derubricare il tema. Quel lavoro c’è e si sono fatti passi avanti in termini di consapevolezza. Faccio un esempio. Se qualche anno fa facevo vedere ai miei studenti la compilazione di un re-captcha nessuno sapeva che dietro quella digitazione di alcune lettere c’era un lavoro di digitalizzazione di libri.

Adesso io entro in aula, faccio questa stessa cosa, e anziché lettere trovo strisce pedonali o semafori e tutti gli studenti sanno che sto lavorando per perfezionare il riconoscimento della segnaletica per le auto a guida autonoma.
Rimane il fatto che la rete è piena di meccanismi volti a estrarre valore che non viene redistribuito. Valore generato dalle nostre attività gratuite.
Per fortuna le nuove generazioni sono da questo punto di vista molto più alfabetizzate di quanto non lo siano quelle precedenti. Conoscono le regole del gioco, anche se talvolta scelgono di stare al gioco.
Ciò non toglie che rimanga forte il bisogno di inventare modelli alternativi più etici e giusti e soprattutto con meccanismi redistributivi.
A che punto siamo con le piattaforme alternative?
Possiamo dire che è in corso un bell’esercizio in tal senso, ma niente di più. Dobbiamo ammettere che questi modelli alternativi al momento, non riescono a stare sul mercato. Sono modelli giusti dal punto di vista ideale, valoriale ed etico e proprio perché tali non dobbiamo far finta che stiano funzionando.
In tutta franchezza devo dire che sono molto critica nei confronti del movimento del Platform cooperativism quando si racconta come un caso di successo.

Se vogliamo che abbia successo dobbiamo cominciare a dire che oggi non ce l’ha. Non abbiamo a che fare con una profezia che si autoavvera.
Non basta dire che Fairbnb funziona per farlo funzionare. Dobbiamo dirci che Fairbnb è una splendida idea a cui hanno lavorato tante persone per diversi anni e che non ha avuto successo e temo mai lo avrà.
È proprio chi crede a questi modelli più giusti e vuole muovere in tale direzione che dovrebbe fare una riflessione in grado di analizzare sul serio i problemi di queste piattaforme alternative e cercare di affrontarli anziché autocelebrarsi in convegni dove si presentano sempre gli stessi casi facendo finta che funzionino.
Le piattaforme sono neutre rispetto al genere? O ripropongono o addirittura esasperano “on line” disuguaglianze già evidente “on life”?
Le piattaforme al momento riproducono le disuguaglianze di genere diffuse in vari ambiti della società. In questo senso possiamo dire che “rinforzano” tali disuguaglianze.
Si tratta di aspetti interessanti dal punto di vista della ricerca e su cui sarebbe interessante fare un’ulteriore riflessione perché sono dinamiche complesse che non si possono liquidare semplicisticamente.
In una ricerca che ho fatto sulle lavoratrici domestiche che operano attraverso piattaforme che intermediano l’incontro tra domanda e offerta di lavoro per fare le pulizie in casa o su piattaforme di baby sitting, ho intervistato numerose donne over 50 che mi hanno raccontato come siano riuscite a trovare lavoro grazie a quelle poche piattaforme che non obbligano il lavoratore a inserire la propria fotografia.
In che senso?
Perché senza fotografia, che mostra l’età della lavoratrice, la scelta avveniva sulla base delle valutazioni, delle recensioni e non sulla base del dato anagrafico.
Questo consentiva loro di accedere al colloquio e di giocarsi la carta della competenza, bypassando il “blocco” dell’età. È un aspetto non irrilevante in quanto ha a che fare con le possibilità di accesso al lavoro e anche con la discriminazione che le piattaforme possono favorire o alleviare.
Un altro caso interessante è quello di Airbnb su cui sono state fatte numerose ricerche che hanno dimostrato il meccanismo della riproduzione della discriminazione in atto su quella piattaforma. In particolare discriminazioni dal punto di vista etnico dove si è dimostrato che per un afroamericano era più difficile,non solo essere accolto come ospite negli appartamenti, ma anche nel caso di offerta di alloggio (a parità di caratteristiche con quelle di un bianco) era costretto tenere un prezzo più basso.
Come si può intervenire in questi casi?
Non è semplice in quanto non trattandosi di un albergo ma di una casa privata non puoi introdurre norme antidiscriminatorie né imporre a una persona di accoglierne un’altra nella propria casa. Ma il dibattito partito da queste ricerche ha indotto Airbnb a togliere le fotografie e tutta la dimensione di presentazione di sé dell’host. Faccio però notare che questo passaggio Airbnb lo ha fatto nella sua transizione da una piattaforma peer-to-peer a una piattaforma commerciale in senso stretto. Nel momento in cui si è accorta che l’80% degli appartamenti era gestito da bed&breakfast o da agenzie immobiliari, ha capito che tutta la parte di presentazione non serviva più, perché era il modello peer to peer che era saltato.
Quindi non genuina volontà antidiscriminatoria, ma presa d’atto della residualità del modello peer-to-peer e quindi della non centralità del costruire fiducia e relazione.
È chiaro quindi che se volessimo mantenere la dimensione relazionale, è necessario fare i conti con questi e altri aspetti come il fenomeno che in sociologia viene definito col concetto di “omofilia”.
Di cosa si tratta?
Si tratta di quel fenomeno che tende a farci relazionare più facilmente con persone che ci somigliano, che percepiamo come più simili a noi. Che non produce discriminazione consapevole (ideologica per certi versi) ma discrimanzione generata dalla familiarità percepita nella somiglianza.
Si è dimostrato infatti che anche i colloqui di selezione o di promozione nel mercato del lavoro sono influenzati da questo fenomeno per cui se è un uomo a fare selezione è più probabile che si scelga un uomo e viceversa, senza che con questo si siano messi in moto, deliberatamente, meccanismi discriminatori.
Tutto questo per dire che se vogliamo introdurre in una piattaforma commerciale l’aspetto relazione, dobbiamo tener conto del fatto che le persone tendono a privilegiare i propri simili alimentando risultati discriminatori.
Il sogno di un modello di economia e sociale fair e accessibile mediato da tecnologie social, che pure era alla base dell’internet pionieristico, è stato fagocitato da business model che alimentano nuovi oligopoli capitalistici basate su logiche estrattive del valore. È solo potenza della tecnologia e del profitto o c’è anche una controspinta simbolico-narrativa che ha alimentato il fenomeno? In due parole c’è un fondamento simbolico dell’attività pratica delle piattaforme?
L’immaginario è sempre stato importante e oggi lo è ancora di più. E credo che in proposito sia importante partire dal bel libro scritto negli anni ‘90 da Luc Boltanski e Eve Chiappello: Il nuovo spirito del capitalismo.
Tra le analisi importanti fatte in quel libro ce n’era una che evidenziava la capacità del sistema capitalistico di accogliere le istanze critiche e di reimpacchettarle per restituirle all’interno di un meccanismo di appropriazione che si alimenta con la costruzione di immaginario.
Per semplificare, la libertà dei lavoratori partita nel ‘68 è diventata “tutti liberi di essere imprenditori di sé stessi”.
Oppure, altro esempio emerso dalle sue analisi di vent’anni fa, è quello che dimostrava come i documenti e la contestazione del capitalismo e della globalizzazione nati nei socila forum di Porto Alegre erano stati “ripresi” dal successivo G8.
È forse in questa prospettiva che si può leggere oggi il dibattito su “le Grandi dimissioni” e il tema del senso nel lavoro. La risposta la vediamo in un proliferare di Bcorp e di aziende con il purpose che è costruzione e riappropriazione di un immaginario nato altrove.
Per tornare al tema delle piattaforme è la stessa cosa del passaggio dalla sharing economy alla gig economy. Uber che dice io sono sharing economy danneggia chi vuole davvero esserlo. Perché poi nella critica a Uber è stata trascinata tutta la sharing economy, anche quella che si poteva definire legittimamente tale e che aveva delle caratteristiche ben diverse da quelle di Uber.

Ma non è compito della ricerca critica quello di distinguere il grano dal loglio?
Certo sarebbe il suo compito, ma diventa sempre più difficile per via dell’accelerazione dei processi di elaborazione della critica e della sua fase di verifica. Oggi semplicemente non ci sono i tempi di formulazione della critica, di appropriazione della critica e di rielaborazione. Questo produce il collasso simbolico degli universi della critica.
Da quello che dici sembrerebbe che l’”egemonia culturale” dell’economia di piattaforma si sia appropriata di ambiti del non profit arrivando a colonizzare alcune dimensioni fondanti della socialità: la condivisione, la fiducia, la reciprocità e la comunità. Insomma quegli ambiti generativi propri della società civile e di modelli economici come la cooperazione. È così?
Sì è così ma serve uno scarto. A proposito di cooperative ritengo che l’importante dibattito sul Platform cooperativism debba spostare il suo focus da quelle piattaforme nate come “copia e incolla” di modelli estrattivi – corretti magari con una governance democratica e una più equa redistribuzione del valore – e indagare altrove.
Ad esempio dove?
Ad esempio in Italia ci sono esempi di cooperative che il suo servizio ce l’hanno già e che provano a usare le piattaforme per fare trasformazione digitale, ma mantenendo il DNA cooperativo.
È il processo inverso: non si parte dalla piattaforma per innestarvi la governance cooperativa ma si parte dalla cooperativa per disegnare una tecnologia di supporto che sia però coerente con il DNA della cooperativa.
Questa operazione secondo me è altrettanto delicata. Voglio dire che non è più semplice, in quanto ci sono importanti impatti organizzativi, di design e di accessibilità e di comprensione di quali logiche nuove stai incorporando nell’erogazione del tuo servizio.
E non è da escludere qualche crash culturale.
Ad esempio, sto studiando in questo periodo con il progetto weplat, i servizi alla persona offerti da cooperative. Sono piattaforme che hanno altre specificità rispetto ai servizi di delivery ed è evidente come in questi casi sia molto delicato l’innesto di tecnologia.
Per cui se non stiamo consegnando la pizza, ma ci stiamo prendendo cura di qualcuno, dobbiamo prestare molta attenzione a tutti gli aspetti connessi all’innesto di una piattaforma. Tener conto di come impatta l’infrastruttura tecnologica attraverso i vari dispositivi d’accesso ma anche che cosa va incorporato delle logiche organizzative preesistenti e se tali logiche hanno senso oppure no, considerato il contesto cooperativo e la tipologia del servizio di cura.
In altre parole la sfida è adattare lo strumento e la tecnologia al tipo di organizzazione e non il contrario. In questo senso la sfida del platform cooperativism sarebbe di ben altra portata.
E qui un ruolo chiave lo svolgono le competenze degli sviluppatori che sono tutt’altro che neutri nel processo di implementazione. Insomma dove vanno le cooperative a comprare tecnologia e nuovo software? È tecnologia adeguata all’organizzazione? E se non lo è, dove sono le competenze per customizzarle in modo coerente?
Sono domande importanti in quanto hanno a che fare con la capacità di costruire infrastrutture tecnologiche in grado di incorporare nell’organizzazione del lavoro anche i valori e le finalità di quello specifico servizio offerto da quella cooperativa.
Su questi aspetti c’è tanto da studiare perché tanto si sta facendo tra le cooperative e mi piacerebbe avere tempo e risorse per studiare meglio le tante sperimentazioni in corso.

Prima accennava a weplat, un progetto di ricerca sulle piattaforme di welfare. Quali sono le evidenze principali che ha individuato, soprattutto in ambito cooperativo?
Con weplat abbiamo praticamente mappato tutte le piattaforme di welfare del Paese: magari ce n’è sfuggita qualcuna ma direi che se non si è fatta trovare è probabile, per la ratio stessa delle piattaforme, che non sia così decisiva.
Le piattaforme mappate sono circa un centinaio e il loro numero è in crescita.
Le abbiamo suddivise in tre categorie:
- le piattaforme di emanazione pubblica nate su volontà perlopiù di Comuni, ma anche di alcune Regioni;
- le piattaforme fatte dal terzo settore, prevalentemente da cooperative o da consorzi di cooperative che spesso hanno spesso una comune infrastruttura, che poi viene adattata su diversi contesti territoriali.
- E poi invece una terza categoria di piattaforme che sono le start up digitali vere e proprie. Organizzazioni private che offrono servizi alla persona.
Finita la ricognizione abbiamo cominciato a fare interviste e nel prossimo anno e mezzo ci occuperemo di studi di caso.
È ancora presto per esprimersi in maniera compiuta, ma alcuni aspetti emergono chiaramente.
Innanzitutto c’è un tema di “campi organizzativi” che evidenzia come le piattaforme del pubblico e quelle del terzo settore si vedano reciprocamente mentre quelle private non vedono e non sono viste dagli altri due insiemi.
Può spiegare con un esempio?
Certo. Prendiamo le piattaforme per badanti. Se ne sto cercando una posso avvalermi del passaparola oppure cercare in rete digitando su Google “badante a Milano” e dalla ricerca escono di solito nell’ordine, prima le piattaforme per badanti offerte dalle start up digitali nate con quell’obiettivo e poi quelle del pubblico e del non profit.
Solo questo aspetto ci dice già come il posizionamento e l’accessibilità del cliente o utente sia un elemento poco centrale per le piattaforme pubbliche e del terzo settore. Eppure non c’è una ragione dirimente che impedisca alla cooperazione o al pubblico di adottare migliori strategie di posizionamento.
È mancanza di competenze? Scarsa dimestichezza con le logiche del digitale?
Non è solo questo. C’è di più. E lo dico con le parole di un lavoratore di una cooperativa che ho intervistato qualche giorno fa: “Io sono un educatore, non sono un commerciale”.
E ha ragione. Se una persona ha scelto di fare l’educatore lo ha fatto non certo per arricchirsi, ma probabilmente per una scelta valoriale forte. Se avesse voluto fare il commerciale lo avrebbe fatto probabilmente in contesti più remunerativi.
Il tema è che la logica di mercato non solo non è connaturata al settore no profit o cooperativo, ma viene addirittura rifiutata.
Il tema è culturale e non basta la piattaforma. Prima c’è bisogno di costruire una compatibilità, un nuovo mindset, che riesca a mixare logica di mercato senza frustrare una logica di servizio che è il motore di senso di chi opera nel mondo della cooperazione.
Questo non accade con le piattaforme private che sono nativamente orientate al mercato e agli aspetti commerciali e di conversione.
E poi c’è il tema dell’ecosistema competitivo, della competizione tra piattaforme.
Vediamo come si gioca la competizione…
Sappiamo bene che anche tra cooperative c’è sempre stata competizione e nel contesto dei bandi e appalti pubblici, la cooperazione è sempre riuscita a trovare un equilibrio per certi versi “coopetitivo”, che bilancia competizione e cooperazione.
Con le piattaforme e con l’orientamento al mercato degli utenti finali, il gioco diventa completamente diverso e richiede nuovi adattamenti. Una sorta di alfabetizzazione che è in corso e proprio per questo è interessante studiare adesso.
Ad esempio la cooperazione abituata a fare gare d’appalto, dove sa bene come muoversi, se deve definire un servizio rivolto all’utente finale, non è capace di costruire “il prezzo”, semplicemente perchè non l’ha mai fatto.
Così come il raccontarsi. On line non ci si può raccontare con linguaggio tecnico e in “burocratese” necessario magari nei bandi; oppure con le stesse parole usate nelle relazioni di accreditamento di un servizio da parte di un Ente Pubblico. Diventa illeggibile in rete.
Quindi mi sembra di capire che non sia la tecnologia il vero tema.
La tecnologia ormai la sanno usare tutti ed è comunque accessibile. Il vero tema per la cooperazione è chiedersi se la logica delle piattaforme gli va bene oppure no. Significa interrogarsi su come ci si pone di fronte a quella logica e se la mia cultura d’impresa è coerente con quella logica o ancora meglio se può cambiare o ibridare quella logica.
Perché il passaggio dal bando all’utente finale è un cambio di paradigma di non poco conto.
Lei è componente del comitato scientifico della Fondazione Pico di Legacoop. Quali sono i terreni dove la cooperazione potrebbe esprimere un vantaggio competitivo a base piattaforma? Ad esempio sul tema dei dati.
Quella delle cooperative che mettono al centro i dati è una strada sicuramente da percorrere. Ma eviterei una lettura piuttosto ingenua che pensa alla redistribuzione del valore generato dal dato. Vista così possiamo stare certi che ci porteremmo a casa 2 euro all’anno, che non è un gran risultato. L’esercizio vero da fare sarebbe invece quello di capire che tipo di progettualità e di innovazione sociale si può generare con quei dati, magari circoscritti a un territorio.
Che innovazione di servizi posso generare su quei territori. È chiaro che in questo caso posso generare valore aggiunto nell’offerta di servizi al territorio e alla collettività e non semplicemente monetizzare il dato direttamente. In questo senso una cooperativa di dati, ma anche un’azione del pubblico in tal senso, potrebbe essere molto interessante.
Un altro ambito promettente a mio parere che sto studiando nel mondo della cooperazione, è l’emergere di meccanismi di “voice”, per dirla con Hirschmann. Si tratta di comportamenti proattivi e politici nell’attuazione di determinati provvedimenti che, a mio parere, derivano dal fatto che la cooperazione ha più presa sui bisogni di un territorio di quanto non ne abbia il sindacato. Ad esempio sui rider la presa della cooperazione è stata più tempestiva di quella del sindacato. Oppure durante la pandemia si è vista un’importante azione di advocacy anche su tavoli ministeriali, da parte di Doc Servizi, relativamente al disagio dei lavoratori dello spettacolo.
L’Europa e la direttiva sulle piattaforme: c’è il rischio di regolamentare qualcosa che nel frattempo è già altrove?
Questo rischio c’è sempre quando la legge prova a regolamentare processi in grande evoluzione. È normale che il diritto segua la vita o i fenomeni economici e sociali e credo non sarebbe neppure giusto se il diritto arrivasse prima: ucciderebbe ogni sperimentazione. Naturalmente se arriva troppo tardi è poi difficile correggere storture.
Per quanto riguarda la Comunità Europea credo sia nei giusti tempi per esprimersi sulle Piattaforme.
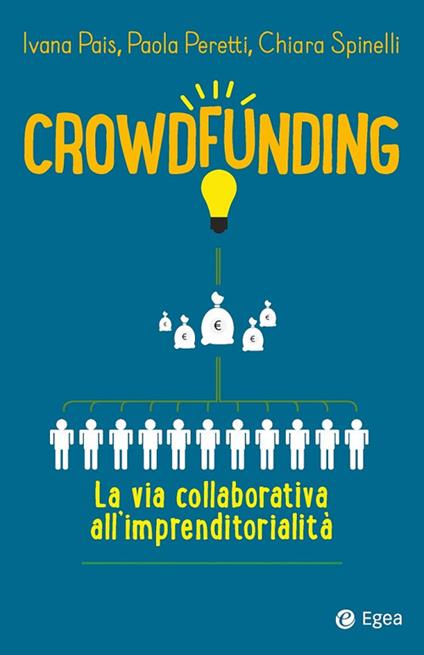
La cooperazione ha sempre sofferto di scarsa capitalizzazione. Le piattaforme di crowdfunding possono essere una prospettiva interessante nei processi imprenditoriali a base cooperativa?
Sì se lo si considera come un canale di finanziamento complementare. Non funziona se lo si considera un canale alternativo, quasi salvifico, di una struttura finanziaria debole. Le multinazionali hanno oggi alle loro spalle una struttura finanziaria “paziente” ovvero capitale che sa aspettare e che non è più come quello di alcuni anni fa che cercava un ritorno immediato. Il finanziamento tramite crowdfunding può aiutare, ma certo non sopperire a una debolezza complessiva del sistema di finanziamento. È un tassello di una strategia integrata che deve costruire un giusto mix di risorse da cui attingere.
C’è il rischio che le piattaforme si “mangino” le cooperative? Ad esempio nel settore taxi dove abbiamo visto Uber siglare accordi a Roma e Bologna.
Credo che il tempo, o meglio, la velocità su questo tema sia una variabile importante. Non conosco nel dettaglio il settore dei taxi ma in via generale al terzo settore, con cui dialogo sovente, ripeto in continuazione quanto sia importante avviare rapidamente la transizione tecnologica, prima che arrivi Amazon o qualsiasi altra piattaforma globale.
Fa la differenza per una piattaforma globale trovare un settore completamente sguarnito dal punto di vista digitale oppure no. Nel primo caso il rischio è che si prenda l’intero mercato. Nel caso di infrastrutturazione digitale e di radicamento locale è più difficile.
Se il campo è già seminato ci sono più possibilità di tenerlo.
Per rimanere sul welfare che conosco meglio, c’e’ da dire che Amazon Care in Italia ancora non c’è. Giochiamocela allora.
Change-Makers è il magazine digitale che racconta idee, storie, protagonisti del cambiamento. Scriviamo di cooperazione e innovazione sociale, ambientale, economica, digitale, organizzativa, etica e filosofica.
Se vuoi restare in contatto con noi iscriviti alla nostra newsletter.









